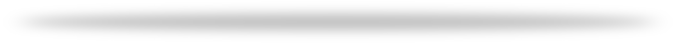* * *
Leggendo un passo molto noto del Vangelo, sono rimasto folgorato dal seguente versetto: “un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta”.
Avrete riconosciuto sicuramente l’inizio della parabola del figliol prodigo, un brano che tutti conosciamo bene.
L’espressione “dammi la parte che mi spetta” ha iniziato a risuonarmi nel cervello come fosse la prima volta che la leggevo. E, al tempo stesso, ne avvertivo la familiarità di chi la sente pronunciare ossessivamente ogni giorno. Per la prima volta mi sono reso conto che proprio questa frase, che oggi è di moda proclamare con fierezza, è l’origine di tutta la successiva rovina alla quale il giovane andrà incontro.
Ma come? Mi sono detto. Come è possibile che l’intera catastrofe esistenziale di questo ragazzo tragga origine proprio da una frase del genere? Come è possibile, cioè, che la rivendicazione di un diritto giusto possa portare il giovane a diventare servo e ad invidiare i porci?
Ecco perché sono rimasto sorpreso: perché io stesso mantengo la mia famiglia per il fatto di aiutare la gente a rivendicare i propri diritti, a rendere efficace la frase: “dammi la parte che mi spetta”.
Attenzione: il ragazzo chiede quel che gli spetta, ne ha diritto. Tuttavia, da questo momento, proprio per aver esercitato questo suo incontestato diritto, andrà incontro alla sua stessa rovina, finirà col diventare guardiano di porci.
Il fatto è che noi tutti conferiamo un carattere sacrosanto ai nostri diritti e pensiamo, quindi, che l’esercizio degli stessi corrisponda automaticamente al nostro bene, alla realizzazione della nostra stessa vita. Ma non è così. O, almeno, non è così automatico. Tra l’ottenere la parte che ci spetta e la nostra felicità c’è una cesura che ci deve indurre a riflettere sul fatto che, talvolta, l’esercizio dei nostri diritti contiene un aspetto oscuro, uno spazio d’ombra in cui può insinuarsi pericolosamente il germe della nostra rovina. Uso il termine “pericolosamente” proprio per il fatto che questa intrusione risulta per noi invisibile, dato che siamo convinti di muoverci nell’ambito delle nostre ragioni, dei nostri diritti, per cui abbassiamo qualunque difesa. Se abbiamo ragione, siamo convinti che non possiamo né fare il male, né subirlo. È come se muoversi nell’ambito della giustizia costituisse un antidoto sicuro, una garanzia.

“Dammi la parte che mi spetta” costituisce indubbiamente un atto di giustizia formale, ma non dice nulla sui legami di appartenenza che questo comportamento recide, sugli abbandoni e le separazioni che determina. Qualche volta, infatti, alla giustizia formale non corrisponde la giustizia sostanziale. Il giovane della parabola, ottenendo la parte che pure gli spettava, ha rinunciato a quel che di più prezioso aveva (la vicinanza al padre) per recarsi in un paese lontano, dove non conosceva nessuno e dove, soprattutto, non significava nulla per nessuno. Ma oggi l’esercizio dei nostri diritti è diventato un totem intangibile.
Il fatto è che la giustizia da sola non basta, non è sufficiente a realizzare quel che vogliamo. Una società giusta non per questo sarà automaticamente felice e pacifica.
E allora mi sono ricordato di Luciano De Crescenzo, quando affermava: “non che a Milano i milanesi non fossero gentili con me (anzi!), ma lo erano sempre e poi lo erano con tutti … Capii subito che sarebbero stati ugualmente gentili anche se io fossi stato un altro e questa mancanza di discriminazione nei miei confronti mi fece star male. In altre parole, io cercavo una prova della mia esistenza e loro mi sommergevano di cortesie indifferenziate. Ricordo che una sera andai alla Rinascente e supplicai le commesse di trattarmi in modo più personale. “Signorine, vi prego”, dissi loro, “se proprio non potete farmi uno sconto, fatemi almeno pagare qualcosina in più, magari solo cento lire, perché la mia venuta, questa sera, lasci una traccia nel vostro cuore”. Niente da fare: mi scambiarono per un maniaco”.
Ma allora è vero: la giustizia non basta all’essere umano e forse occorre riuscire a intrattenere un rapporto più libero con i nostri diritti.
De Crescenzo, in fondo, si lamentava di una società giusta, che riconosce a ciascuno la dovuta dose di cortesia, sempre uguale. Ma poi ci accorgiamo che un simile modello sociale non ci appaga, sebbene da secoli dottrine e filosofie seguitissime facciano coincidere il concetto di giustizia con quello di uguaglianza, insegnando che la realizzazione di una società uguale e giusta renderebbe felice l’uomo.
Ma perché, allora, De Crescenzo soffriva tanto? Per l’astrattezza, credo, cioè per la mancanza di personalizzazione con cui la cordialità gli veniva elargita. Può sembrare paradossale, ma l’applicazione astratta e impersonale della giustizia può ferire l’uomo.
La considerazione dell’unicità di ogni singola persona, infatti, è l’elemento essenziale senza il quale la giustizia si trasforma automaticamente in meccanismo disumano. Ecco perché De Crescenzo soffriva a Milano, proprio per quel trattamento omologato e spersonalizzato che lo faceva dubitare addirittura della sua stessa esistenza.
No, la giustizia non è sufficiente.