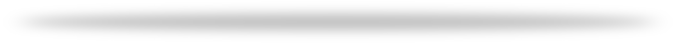Nel ciclo della comunicazione d'impresa, la sostenibilità ha attraversato tutte le sue stagioni: è stata moda, urgenza etica, leva di posizionamento, bandiera di progresso. Oggi, dopo la corsa all’ESG e i riflessi condizionati del greenwashing, qualcosa sembra essersi incrinato. Il termine stesso – ESG – è finito nel mirino della reazione culturale. Negli Stati Uniti, dove la politica ha riscritto l'agenda climatica e deregolato l’orizzonte finanziario, la sostenibilità è diventata bersaglio di una critica ideologica che la riduce a espressione del “woke capitalism”. I numeri poi parlano chiaro: nel 2024 sono stati ritirati oltre 20 miliardi di dollari dai fondi ESG (Morningstar report Morningstar Q4 2024). Il sentimento è mutato. Quello che era il terreno dell’innovazione sociale si è trasformato in un fronte di polarizzazione politica.
In Europa, dove risiede oltre l’80% degli asset ESG globali, lo scenario è meno infuocato ma altrettanto complesso. Le grandi ambizioni regolatorie – dalla Tassonomia alla SFDR, dalla CSRD al Green Deal – hanno prodotto un sistema avanzato ma appesantito, che oggi fatica a tenere insieme rigore normativo e attrattività del mercato. Sempre secondo l’ultimo sondaggio Morningstar, i fondi Articolo 9 hanno registrato deflussi per 7,3 miliardi di euro, il peggior risultato dalla loro introduzione. È il quinto trimestre consecutivo in calo. Al contrario, i fondi Articolo 8 – spesso più ampi, talvolta opachi – continuano ad attrarre capitali (+52 miliardi nello stesso periodo). In questa tensione tra esigenza di impatto e logica di mercato, la finanza sostenibile europea si trova oggi costretta a ridefinire il proprio lessico e, forse, il proprio statuto.
E in Italia? Il quadro è più rarefatto, ma proprio per questo fertile. In un panorama (lievemente) meno saturo di retorica e meno esposto alle oscillazioni ideologiche, la sostenibilità mantiene margini di concretezza. Secondo il Cerved ESG Score 2024, nel nostro paese il 75% delle imprese ha avviato almeno un’iniziativa in ambito ESG, ma solo il 22% dispone di una strategia formalizzata, con indicatori misurabili. Una distanza significativa, ma non incolmabile. Mentre altrove si affaccia il disincanto, l’Italia potrebbe diventare il laboratorio di un modello diverso: sobrio, integrato, adatto al suo tessuto fatto di filiere, distretti, territori. Un modello che rifiuta la spettacolarizzazione e riscopre il valore della sostanza. Ma per riuscirci, servono strumenti adeguati: un nuovo alfabeto, nuove metriche, nuovi luoghi per misurare e raccontare l’impatto. La sostenibilità – anche qui – è in transizione. E forse proprio per questo vale la pena non voltarsi dall’altra parte.
È proprio per non disperdere ciò che di concreto è stato fatto finora – lontano dai riflettori e dalle oscillazioni semantiche – che nasce Beyond Us, l’Osservatorio di Sostenibilità promosso da 4cFuture. Un progetto che punta a mappare, analizzare e valorizzare le realtà italiane che hanno saputo trasformare la sostenibilità da obbligo formale a infrastruttura culturale e strategica. Nessun premio, nessun ranking da sfoggiare sul sito aziendale. Solo un’operazione di verità: capire dove siamo e come, con metodo, possiamo proseguire.
L’architettura dell’Osservatorio si sviluppa su quattro direttrici: rigenerazione ambientale, tutela territoriale, inclusione sociale ed etica dei processi. Ogni dimensione è analizzata con criteri chiari, coerenti, replicabili. Perché parlare di sostenibilità senza strumenti di misurazione significa accontentarsi della superficie. E raccontare l’Italia sostenibile senza tenere conto delle sue specificità – distretti, filiere, comunità produttive – significa tralasciare e depotenziare il contesto.
Mentre altrove si riscrive la grammatica della finanza responsabile, qui possiamo scrivere un’altra storia. Più lenta, forse. Meno spettacolare. Ma più nostra. E più resistente alle mode. Perché se è vero che la parola ESG rischia l’obsolescenza, non lo sono le pratiche che ha contribuito a generare. Efficientamento, coesione, tracciabilità, impatto: nessuno ha detto che dobbiamo smettere di farle. Forse dobbiamo solo smettere di venderle come delle “specialissime novità”.
Il percorso dell’Osservatorio culminerà in un report annuale e in una mappa delle eccellenze italiane, concepiti come strumenti di lavoro consultabili, con forti potenzialità di connessione tra attori diversi. Non per raccontarci che tutto va bene, ma per mettere a sistema ciò che funziona. Perché la sostenibilità non ha bisogno di palchi, ma di spazi comuni dove chi crede nel cambiamento possa guardarsi in faccia.
Nel 2025, più che di nuove parole, abbiamo bisogno di nuovi criteri per credere a quelle vecchie. Se smettiamo di chiamarla ESG, chiamiamola sostenibilità. Ma continuiamo a praticarla. Perché tra il sarcasmo dei cinici e le iperboli degli entusiasti, serve una terza via: quella di chi lavora per costruire.